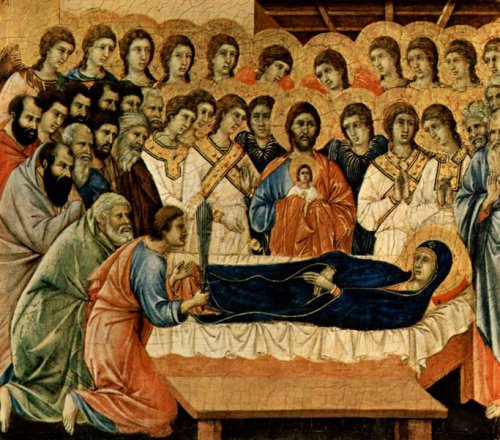EPARCHIA DI LUNGRO
XXIV Assemblea Diocesana
e
Corso di aggiornamento teologico
II SINODO INTEREPARCHIALE
Eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi
E Monastero Esarchico di S.M. di Grottaferrata
ORIENTAMENTI PASTORALI
E NORME CANONICHE
S. Cosmo Albanese
Casa del Pellegrino
29 ‘ 30 ‘ 31 agosto 2011
Al Rev.mo Clero, Religiose e Fedeli laici.
Carissimi,
Vi invito a prendere parte all’Assemblea Annuale Diocesana e al Corso di Aggiornamento Teologico che si terranno a S. Cosmo Albanese nella Casa del Pellegrino.
Sono invitati a partecipare tutte le componenti dell’Eparchia: Sacerdoti, Religiose, Chierici, Insegnanti di Religione, Catechisti, Studenti dell’Istituto di Scienze Religiose e tutti i laici impegnati in Parrocchia.
‘ORIENTAMENTI PASTORALI e NORME CANONICHE del II Sinodo Intereparchiale’.
Il Sinodo Intereparchiale, come risultato tangibile, ricco di contenuti dottrinali e normativi, viene a interpellare la nostra disponibilità personale e comunitaria. Entra nella vita di questa Chiesa e disegna la strada dinanzi a noi per fare nuova la storia di Chiesa italo-albanese che annuncia il mistero di Cristo, lo celebra nell’oggi e rende testimonianza nella comunione.
Il Sinodo è per tanti un’esperienza che ha lasciato segni indimenticabili di cammino insieme, nella Chiesa del Signore, per rinnovare, pregare e riscoprire la missione.
Il Sinodo vi ha visti riuniti per una Chiesa immersa nella storia, radicata nel tempo e sul territorio con il profondo desiderio di essere capace di dare risposte credibili alla gente del nostro tempo. Voi avete fatto l’esperienza di essere Chiesa particolare, sotto l’azione dello Spirito, che si è interrogata sulla sua fedeltà alla missione, sui suoi ritardi, sulle nuove prospettive, alla luce del Concilio Vaticano II, del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e della propria tradizione.
Vogliamo accogliere sulla nostra Chiesa una nuova venuta dello Spirito, che genera tensione forte, rinnova abitudini e suscita attese feconde.
I vede bene che il suo messaggio più luminoso si compendia nell’esigenza di suscitare un clima e uno stile di rinnovamento spirituale, pastorale e strutturale. La consegna del Libro sinodale nelle mani di tutti è un fatto carico di futuro per la storia della Chiesa italo-albanese.
Ne dobbiamo prendere atto tutti; non posso non sottolineare il ruolo di responsabilità primaria dei presbiteri.
A tutti Voi chiedo la preghiera perché il Signore illumini tutti noi, affinché, con mente pura e cuore sincero, possiamo accogliere e comprendere ciò che lo Spirito ci dirà in questo incontro ecclesiale.
Invocando la Benedizione di Dio, Vi saluto con affetto.
Lungro, 11 luglio 2011
+ Padre Salvatore Nunnari
Arcivescovo Metropolita
Amministratore Apostolico
PROGRAMMA
Lunedì 29 agosto 2011
Ore 7,30 Divina Liturgia concelebrata, presieduta da S.E. Mons. Ercole Lupinacci, Vescovo emerito dell’Eparchia
Ore 8,30 Colazione
Ore 10,30 Saluto di Padre Salvatore Nunnari, Amministratore Apostolico
I Relazione dell’Archimandrita Manel NIN, Rettore del Pontificio Collegio Greco e Professore di Liturgia orientale presso l’Ateneo S. Anselmo di Roma, sul tema:
IL DIRITTO PARTICOLARE DELLA CHIESA ITALO-ALBANESE: TEOLOGIA E LITURGIA
BIZANTINA COME ANNUNCIO DEL VANGELO
Ore 12,45 Preghiera dell’Ora sesta
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,30 Vespro
Ore 17,00 Gruppi di studio
Ore 19,30 Pausa
Ore 20,00 Cena
Serata di fraternità
Martedì 30 agosto 2011
Ore 7,30 Divina Liturgia
Ore 8,30 Colazione
Ore 9,30 II Relazione del Prof. Nicola CORDUANO, dottore in Diritto Canonico, sul tema:
IL DIRITTO PARTICOLARE DELLA CHIESA ITALO-ALBANESE: RINNOVAMENTO E PROSPETTIVE PASTORALI
Ore 11,00 Gruppi di studio
Ore 12,45 Preghiera dell’Ora sesta
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,30 Vespro
Ore 16,30 Gruppi di studio
Ore 19,30 Pausa
Ore 20,00 Cena
Serata di fraternità
Mercoledì 30 agosto 2011
Ore 7,30 Divina Liturgia
Ore 8,30 Colazione
Ore 9,30 III Relazione di Mons. Natale LODA, Professore di Diritto Canonico delle Chiese Orientali presso la Pontificia Università Lateranense, sul tema:
IL DIRITTO PARTICOLARE DELLA CHIESA ITALO-ALBANESE COME STRUMENTO DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Ore 11,00 Gruppi di studio
Ore 12,45 Preghiera dell’Ora sesta
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,30 Vespro
Ore 16,30 Relazione dei gruppi di studio seguita da interventi.
Conclusione e Documento finale
NOTE TECNICHE
1. Gli arrivi e le sistemazioni sono previsti per la sera del 28 agosto.
2. La quota complessiva dei tre giorni è di ‘ 20,00.
3. La quota verrà versata alla Segreteria dell’Assemblea all’arrivo.
4. I Rev.mi Presbiteri porteranno il parato completo per le celebrazioni e i libri liturgici.
5. Per chi non pernotta, ma usufruisce dei soli pasti, la quota è di ‘ 5,00 a pasto.
Nota bene: per le prenotazioni telefonare ai seguenti numeri entro il 25 agosto 2011: 0981-947234 – 338.793.74.39.