Polichrònion piìse Kìrios o Theòs ton Panaghiòtaton Patèra imòn Papan Franghìskon, is pollà èti, is pollà èti, is pollà èti!
Il Signore Dio conceda molti anni al nostro Santissimo Padre Papa Francesco, per molti anni, per molti anni, per molti anni!
EPARCHIA DI LUNGRO degli Italo Albanesi dell’Italia Continentale
Diocesi Cattolica Bizantina

Polichrònion piìse Kìrios o Theòs ton Panaghiòtaton Patèra imòn Papan Franghìskon, is pollà èti, is pollà èti, is pollà èti!
Il Signore Dio conceda molti anni al nostro Santissimo Padre Papa Francesco, per molti anni, per molti anni, per molti anni!

Il 9 aprile 2 003 con Decreto di Mons. Ercole Lupinacci veniva istituita la parrocchia “ad personam” San Giuseppe (Santa Maria di Costantinopoli) a Castrovillari, e nominato parroco il Protopresbitero papàs Antonio Bellusci. L’operato del Papàs nel dare riconoscimento giuridico ecclesiale ai cinquemila arbëreshë presenti in città è stato perseguito con tenacia e dedizione.
003 con Decreto di Mons. Ercole Lupinacci veniva istituita la parrocchia “ad personam” San Giuseppe (Santa Maria di Costantinopoli) a Castrovillari, e nominato parroco il Protopresbitero papàs Antonio Bellusci. L’operato del Papàs nel dare riconoscimento giuridico ecclesiale ai cinquemila arbëreshë presenti in città è stato perseguito con tenacia e dedizione.
La comunità arbëreshe di Castrovillari, dopo molti anni, finalmente aveva una rappresentanza giuridica ecclesiastica ricadente nella Diocesi di Lungro; ciò fu possibile grazie alla disponibilità del vescovo di Cassano all’Ionio, Mons. Domenico Graziani, favorevole all’istituzione di una parrocchia di rito bizantino in un territorio esclusivamente di rito romano. A Castrovillari gli arbëreshë accolsero con fervore tale concessione, anche perché già da anni, nella cappella dedicata ai Santi Medici Cosma e Damiano, di proprietà della famiglia Vigna, nel territorio della parrocchia di San Girolamo, la prima e la terza domenica del mese la Divina Liturgia veniva celebrata in rito bizantino. 
L’anno 2009 ha visto, alla presenza di Mons. Ercole Lupinacci, del Vescovo di Cassano Vincenzo Bertolone e del sindaco Franco Blaiotta, in un quartiere della città, la posa della prima pietra della nuova Chiesa e contemporaneamente l’avvio dei lavori di realizzazione della casa canonica. Attualmente la Chiesa è in fase di ultimazione.
![]()
La pianta della chiesa è di stile architettonico bizantino a triconco, ossia con tre absidi; la cupola si eleva su un tamburo ed è in rame. L’Illuminazione interna è assicurata da tre finestre per ciascun’abside e quattro per ogni lato della Chiesa. La facciata centrale è anticipata da un triportico.
Il campanile ad arco ha, al suo interno, tre campane poste su due registri: nel superiore la campana presenta un’incisione della Madre di Dio in Trono (l’affresco presente nella Chiesa Madonna di Costantinopoli) e la scritta Santa Maria di Costantinopoli in Castrovillari; nel livello inferiore, la campana sinistra ha raffigurato lo stemma dell’Eparchia e la scritta Ercole Lupinacci, Vescovo; quella di destra la raffigurazione della Calabria e la scritta “Calabria lavori di Aldo Montalto – Colucci S.”.
All’interno è installata l’iconostasi in legno composta da due ordini. Il primo ordine contiene le icone del Cristo Pantokrator, della Madre di Dio, di San Giuseppe e di San Giovanni Battista; quello superiore le icone dei dodici apostoli, disposte in due file da sei e separate dall’icona della cena mistica.Gli ordini sono separati da una base in cui vi è l’iscrizione greca: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς”. 
Sulla sommità è collocata l’icona del Cristo crocefisso con ai lati la madre di Dio e S. Giovanni evangelista.
Le porte diaconali contengono le icone dei santi diaconi Lorenzo e Stefano; mentre le porte regie l’Annunciazione.
Pregevoli intagli ornano l’iconostasi: i rami e tralci della vite ai due estremi; due pavoni sopra le porte regie, oltre a figure floreali e frutti. Inoltre sotto l’icona di San Giuseppe e San Giovanni Battista è raffigurata l’aquila bicipite, mentre sotto le icone della Madre di Dio e del Cristo, la croce a forma greca.
Le icone sono state scritte dall’iconografo albanese Josif Droboniku.
Nell’abside è collocato l’altare di forma quadrata, sorretto da cinque colonne – rappresentanti Cristo ed i quattro evangelisti – poste sopra una base marmorea.
A destra, nel nartece, è presente il trono vescovile; sulla sinistra è ubicato l’ambone al quale si accede per il tramite di alcuni gradini; significativa è l’aquila bicipite in legno che funge da leggio. Inoltre in basso si legge l’iscrizione “Ky është Biri im i zgjedhuri Atë dëgjoni”.
Attualmente la divina liturgia è celebrata ogni domenica alle 10.30 nella cappella Vigna, dedicata ai Santi Medici.


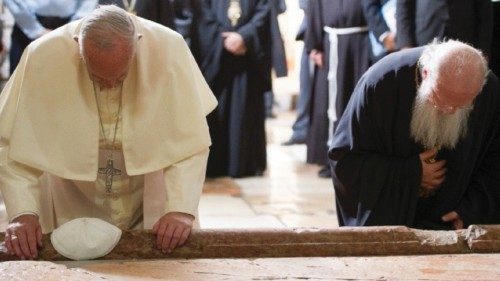
(da L’Osservatore Romano, 9 dicembre 2020)
«L’espressione di una reciproca sincera volontà di riconciliazione» e «un invito a perseguire, in uno spirito di fiducia, di stima e di carità reciproche, il dialogo»: queste parole sono tra le più significative della Dichiarazione comune sottoscritta da Paolo VI e dal Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Atenagora, in occasione della cerimonia, il 7 dicembre 1965, con la quale si procedeva alla contemporanea e reciproca rimozione delle scomuniche tra Roma e Costantinopoli. Con questo atto venivano cancellate le scomuniche pronunciate oltre 900 anni prima, ma sempre valide, il 16 luglio 1054 dai legati pontifici inviati da Leone ix nella capitale dell’Impero bizantino per ottenere l’obbedienza ad alcune questioni dogmatiche contro Michele Cerulario, l’allora Patriarca di Costantinopoli; il 24 luglio dello stesso anno il Sinodo della Chiesa di Costantinopoli ne aveva pronunciate contro gli stessi legati e, di fatto, contro il Pontefice romano per riaffermare l’ortodossia delle posizioni e della figura del Patriarca Cerulario. Queste scomuniche, che non erano altro che l’ultima puntata della lotta per la definizione dei criteri con i quali stabilire l’autorità sulla Chiesa universale, hanno segnato i rapporti non solo tra i cristiani per la valenza politica che le scomuniche avevano assunto anche prima di essere pronunciate, mentre cresceva il clima di tensione tra Roma e Costantinopoli.
La cerimonia della reciproca rimozione si svolse contemporaneamente a Roma, alla vigilia della conclusione del concilio Vaticano II, di fronte a tutti i Padri conciliari, e a Costantinopoli, alla presenza del Sinodo proprio per sottolineare come questo atto non era un’iniziativa personale di due testimoni del Vangelo, ma un passo ufficiale della Chiesa di Roma e della Chiesa di Costantinopoli che insieme decidevano di compiere un gesto di fraternità, nel reciproco perdono, dopo secoli di scontri, di condanne e di silenzi. Un gesto che conteneva in sé un profondo valore simbolico, che andava ben oltre il significato teologico, proprio per il peso che le scomuniche del 1054 avevano assunto nelle relazioni tra cristiani nel corso dei secoli: erano stati celebrati due concili — quello di Lione (1274) e quello di Ferrara-Firenze (1439) — proprio per superare le divisioni che erano state determinate dalle scomuniche che pure avevano fotografato una situazione di tensioni e di sospetti che si era venuti creando nel corso dei secoli tra tradizioni, che avevano assunto forme particolari, pur radicate su un comune patrimonio dottrinale, a causa dei contesti geopolitici tanto diversi con i quali i cristiani si erano dovuti confrontare in Oriente e in Occidente. Sulle forme assunte dalle tradizioni cristiane nel primo millennio ci si è a lungo interrogati, spesso cercando giustificazioni storiche a dichiarazioni dottrinali anche se, negli ultimi decenni, soprattutto in ambito ecumenico, si sono aperte nuove prospettive per la lettura del primo millennio del cristianesimo, nonostante i limiti nella ricostruzione storico-teologica, determinati dalla disponibilità delle fonti, così diversa da luogo a luogo, da secolo a secolo. Al di là delle letture apologetiche che sono state date del 1054, era evidente che questo momento rappresentava una ferita per il corpo della Chiesa, tanto che nel corso dei secoli, oltre ai due Concili nominati, conclusi, soprattutto il secondo, con la sottoscrizione di testi di unione che hanno rappresentato un punto di riferimento per tanti cristiani, non erano mancate le voci di coloro che invocavano la ricostruzione della comunione tra Occidente e Oriente; queste voci, largamente minoritarie, erano state costrette a convivere, fino a venirne soffocate, con quelle, molto più rumorose, di coloro che preferivano leggere il 1054 come un «muro» con il quale tenere separate la verità e l’errore, rivendicando una storia di purezza che non teneva conto della molteplicità di tradizioni formatasi già nel primo millennio e diffuse nel secondo millennio della presenza cristiana anche in considerazione dei nuovi orizzonti missionari che avevano portato il cristianesimo a assumere una dimensione globale. Al rafforzamento di questo «muro» avevano contribuito anche tante vicende politiche, dalla quarta Crociata (1204) al «nazionalismo esasperato» dell’età contemporanea, solo per citarne due tra le più emblematiche anche per la loro attualità, offrendo nuove argomentazioni a coloro che pensavano all’unità in termini di uniformità nella sottomissione.
La cerimonia del 7 dicembre 1965 è stata uno dei primi frutti della nuova stagione nei rapporti tra Roma e Costantinopoli che si era aperta con l’incontro tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora, a Gerusalemme, il 5 gennaio 1964, in un viaggio tanto fecondo per il cammino ecumenico, come testimoniano i tanti passi compiuti da cattolici e ortodossi per superare le divisioni che ancora impediscono la piena e visibile comunione: «a cinquant’anni dall’abbraccio di quei due venerabili Padri, riconosciamo con gratitudine e rinnovato stupore come sia stato possibile, per impulso dello Spirito Santo, compiere passi davvero importanti verso l’unità», come ha ricordato Papa Francesco in occasione del viaggio in Terra Santa, nel maggio 2014, per celebrare, insieme al Patriarca Bartolomeo, il 50° anniversario di quell’incontro.
Molto della cerimonia del 7 dicembre, senza voler togliere niente al coraggio di Atenagora, che si muoveva in un mondo ortodosso diviso al suo interno, anche per la presenza di tanti ortodossi all’interno dell’impero sovietico, si deve a Paolo VI che, con le sue parole e i suoi gesti, aveva chiaramente indicato alla Chiesa, a partire dai Padri riuniti a Roma per il concilio Vaticano II, quanto prioritaria egli considerasse la ricerca delle strade per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa, così da mettere fine al tempo delle divisioni e delle contrapposizioni. Nella ricerca di queste strade si manifestava il desiderio di vivere la piena comunione con tutti i fratelli e le sorelle in Cristo, a cominciare da coloro che condividevano la propria confessione, senza creare alcun rapporto privilegiato, come alcuni tentarono di sostenere, anche alla luce dei rapporti tra Roma e Costantinopoli o tra Roma o Canterbury, aggiungendo divisioni a divisioni, mentre invece era il comandamento evangelico dell’amore per l’unità che guidava Papa Montini. In questo contesto si inserisce la cerimonia della contemporanea e reciproca cancellazione delle scomuniche che tanto aiutò i cristiani a considerare il passato non semplicemente come un peso nel cammino ecumenico, ma come una memoria da conoscere per promuovere una riconciliazione, radicata sulla conversione dei cuori, dal momento che «più stretta sarà la comunione [dei cristiani] col Padre, col Verbo e con lo Spirito Santo, tanto più intima e facile potranno rendere la fraternità reciproca» (Unitatis redintegratio n. 7).
di Riccardo Burigana

“Vademecum”, etimologicamente significa “vieni con me”. Il documento che vi presentiamo oggi è stato pensato come una guida, una bussola, o come un compagno di viaggio, per il cammino ecumenico del Vescovo assieme alla sua diocesi. Vorrei brevemente presentare lo scopo, la preparazione e il contenuto di questo nuovo documento del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.
Scopo
Il Vademecum ecumenico è nato da una richiesta avanzata dai membri e dai consultori del Dicastero durante la plenaria del 2016. Essi espressero l’auspicio di un breve documento che potesse incoraggiare, assistere e guidare i Vescovi cattolici nel loro servizio di promozione dell’unità dei cristiani attraverso il loro ministero.
Infatti, se il Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo del 1993 è il documento di riferimento per il compito ecumenico dell’intera Chiesa cattolica, si avvertiva la mancanza di un testo destinato ai Vescovi per l’adempimento delle loro responsabilità ecumeniche.
Il Vescovo non può considerare la promozione dell’unità dei cristiani semplicemente come uno dei tanti compiti del suo ministero, un compito che potrebbe o dovrebbe essere posposto ad altre priorità, apparentemente più importanti. L’impegno ecumenico del Vescovo non è una dimensione opzionale del suo ministero, bensì un dovere e un obbligo.
Preparazione
Il processo di preparazione del Vademecum è durato circa tre anni. Una prima bozza è stata preparata dagli officiali del Pontificio Consiglio con la consulenza di esperti, e poi presentata durante la plenaria del Dicastero nel 2018. Il testo è stato in seguito inviato a numerosi Dicasteri della Curia Romana, che vorrei qui calorosamente ringraziare per il loro prezioso contributo.
Le linee guida del Vademecum si basano sul Decreto Unitatis redintegratio del Concilio Vaticano II, sull’Enciclica Ut unum sint, e su due documenti del Pontificio Consiglio: il Direttorio ecumenico e La dimensione ecumenica nella formazione di chi si dedica al ministero pastorale. Non si trattava, tuttavia, di ripetere questi documenti, ma piuttosto di proporre una breve sintesi, aggiornata e arricchita dai temi portati avanti nel corso degli ultimi pontificati, e sempre adottando il punto di vista del Vescovo: una guida che possa ispirare lo sviluppo dell’azione ecumenica e che sia di facile consultazione.
Il Santo Padre ha approvato il Vademecum e vi ha fatto riferimento nella sua Lettera del 24 maggio scorso in occasione del 25° anniversario dell’Enciclica Ut unum sint (1995). Ricordando che “il servizio dell’unità è un aspetto essenziale della missione del Vescovo”, Papa Francesco ha espresso l’auspicio che il Vademecum serva come “incoraggiamento e guida” all’esercizio delle responsabilità ecumeniche dei Vescovi.
Il Pontificio Consiglio si è dato premura di preparare la traduzione del Vademecum in diverse lingue. Per il momento sono pronte le versioni in inglese, italiano, francese, spagnolo, portoghese e tedesco.
La pubblicazione del Vademecum ecumenico segna non solo il 25° anniversario dell’Enciclica Ut unum sint, ma anche un altro importante anniversario per l’impegno ecumenico della Chiesa cattolica: il 60° anniversario dell’istituzione del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, avvenuta in seguito all’annuncio del Concilio Vaticano II. Per celebrare queste due ricorrenze si terrà questo pomeriggio un Atto accademico trasmesso in diretta streaming dall’Angelicum.
Contenuto
Per quanto riguarda il contenuto, il documento si articola in due parti. La prima parte, intitolata “La promozione dell’ecumenismo nella Chiesa cattolica”, espone ciò che viene richiesto alla Chiesa cattolica nell’adempimento della sua missione ecumenica. Infatti, come afferma il Vademecum “La ricerca dell’unità è innanzitutto una sfida per i cattolici” (6). In questa prima parte il Vademecum prende dunque in considerazione le strutture e le persone attive in campo ecumenico a livello diocesano e nazionale, la formazione ecumenica e l’uso dei mass media diocesani.
La seconda parte, intitolata “Le relazioni della Chiesa cattolica con gli altri cristiani”, esamina quattro modi in cui la Chiesa cattolica interagisce con altre comunità cristiane. Il primo modo è quello dell’ecumenismo spirituale, che, come dice il Concilio, è l’“anima del movimento ecumenico” (UR §8). Il Vademecum sottolinea in particolare l’importanza delle Sacre Scritture (20), dell’“ecumenismo dei santi” (22), della purificazione della memoria (24).
Il secondo modo è il dialogo della carità, che si occupa della promozione di una “cultura dell’incontro” a livello di contatti e di collaborazione quotidiani, alimentando e approfondendo la relazione che già unisce i cristiani in virtù del battesimo. Come dice San Giovanni Paolo II nell’Enciclica Ut unum sint: “il riconoscimento della fraternità […] va ben al di là di un atto di cortesia ecumenica e costituisce una basilare affermazione ecclesiologica” (UUS 42). Il Vademecum fa alcune raccomandazioni pratiche al riguardo; per esempio assistere, per quanto possibile e opportuno, alle liturgie di ordinazione o insediamento dei responsabili di altre Chiese, invitare i responsabili di altre Chiese a celebrazioni liturgiche e ad altri eventi significativi della Chiesa cattolica.
Il terzo modo è il dialogo della verità, che si riferisce alla ricerca della verità di Dio che i cattolici intraprendono insieme ad altri cristiani attraverso il dialogo teologico. Sono qui menzionati alcuni principi del dialogo come scambio di doni (27), del dialogo teologico che “non cerca un minimo comune denominatore teologico sul quale raggiungere un compromesso, ma si basa piuttosto sull’approfondimento della verità tutta intera” (28). Il documento menziona la sfida della ricezione che deve coinvolgere l’intera Chiesa nell’esercizio del sensus fidei (30).
Il quarto modo è il dialogo della vita. Con questa espressione si designano occasioni di scambio e di collaborazione con altri cristiani in tre campi principali: la cura pastorale, la testimonianza al mondo e la cultura. Per quanta riguarda l’ecumenismo pastorale il Vademecum affronta temi come la collaborazione nel campo della missione e della catechesi (34), i matrimoni misti (35), la communicatio in sacris (36). Nel campo dell’ecumenismo pratico il Vademecum tratta della collaborazione nel servizio al mondo (38), e del dialogo interreligioso come sfida ecumenica (39). Infine il documento tratta dell’ecumenismo culturale, in particolare mediante progetti comuni in ambito accademico, scientifico e artistico (41).
Il Vademecum non solo ricorda i principi dell’impegno ecumenico del Vescovo ma, alla fine di ciascuna sezione, riporta un elenco di “raccomandazioni pratiche”, che riassumono in termini semplici e diretti i compiti e le iniziative che il Vescovo può promuovere a livello locale e regionale. Infine, un’Appendice offre una breve descrizione dei partner della Chiesa cattolica nei dialoghi teologici internazionali bilaterali e multilaterali e dei principali frutti già raccolti.
Papa Francesco spesso ribadisce che l’unità si fa camminando; se camminiamo insieme con Cristo, Lui stesso realizzerà l’unità. “L’unità non verrà come un miracolo alla fine: l’unità viene nel cammino, la fa lo Spirito Santo nel cammino” (Basilica di San Paolo fuori le Mura, 25 gennaio 2014). Possa questo Vademecum essere un aiuto sul cammino dei Vescovi e di tutta la Chiesa cattolica verso la piena comunione per la quale il Signore ha pregato. Grazie.

( da L’Osservatore Romano, 30 novembre 2020)
Nel quadro del tradizionale scambio di delegazioni per le rispettive feste dei santi patroni — il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei santi Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di sant’Andrea – il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, ha guidato la delegazione della Santa Sede per la festa del Patriarcato ecumenico. A comporla erano il segretario del dicastero, il vescovo Brian Farrell, e il sottosegretario, monsignor Andrea Palmieri. A Istanbul, si è unito il nunzio apostolico in Turchia, l’a rcivescovo Paul F. Russell. La delegazione della Santa Sede ha preso parte alla solenne Divina liturgia presieduta dal patriarca ecumenico Bartolomeo I nella chiesa patriarcale di San Giorgio al Fanar. Il cardinale Koch ha consegnato al patriarca ecumenico un messaggio autografo del Santo Padre, di cui ha dato pubblica lettura alla conclusione della Divina liturgia. Ne pubblichiamo di seguito una traduzione dall’inglese.
A Sua Santità Bartolomeo
Arcivescovo di Costantinopoli
Patriarca Ecumenico
Nella festa dell’Apostolo Andrea, amato fratello di san Pietro e santo patrono del Patriarcato Ecumenico, esprimo con gioia a Sua Santità la mia vicinanza spirituale ancora una volta attraverso la delegazione. Mi unisco a lei nel rendere grazie a Dio per i ricchi frutti della divina provvidenza, manifesti nella vita di sant’Andrea.
Allo stesso modo prego affinché, attraverso la potente intercessione di nostro Signore, che lo chiamò per essere tra i suoi primi discepoli, benedica abbondantemente lei, i suoi fratelli nell’episcopato e i membri del Santo Sinodo, e tutto il clero, i monaci e i laici fedeli riuniti per la Divina Liturgia celebrata nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio al Fanar. Richiamare alla mente la carità, lo zelo apostolico e la perseveranza di sant’Andrea, è una fonte d’incoraggiamento in questi tempi difficili e critici. Rendere gloria a Dio rafforza anche la nostra fede e la nostra speranza in colui che accolse nella vita eterna il santo martire Andrea, la cui fede resistette nell’ora di prova.
Ricordo con grande gioia la presenza di Sua Santità all’incontro internazionale per la pace tenutosi a Roma il 20 ottobre scorso, con la partecipazione di rappresentanti di varie Chiese e di altre tradizioni religiose. Oltre alle sfide poste dall’attuale pandemia, la guerra continua ad affliggere molte aree del mondo, mentre nuovi conflitti armati emergono per rubare le vite di innumerevoli uomini e donne. Indubbiamente tutte le iniziative prese da organismi nazionali e internazionali, volte a promuovere la pace, sono utili e necessarie, tuttavia conflitto e violenza non cesseranno mai finché tutte le persone non raggiungeranno una più profonda consapevolezza di avere una responsabilità reciproca come fratelli e sorelle. Alla luce di ciò, le Chiese cristiane, insieme con altre tradizioni religiose, hanno un dovere primario di offrire un esempio di dialogo, mutuo rispetto e cooperazione pratica.
Con profonda gratitudine a Dio, ho sperimentato questa fraternità in prima persona nei vari incontri che abbiamo condiviso. A tale proposito, riconosco che il desiderio di una sempre maggiore vicinanza e comprensione tra cristiani si è manifestato nel Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli prima che la Chiesa cattolica e altre Chiese s’impegnassero nel dialogo. Ciò si può chiaramente vedere nella lettera enciclica del Santo Sinodo del Patriarcato Ecumenico rivolta alle Chiese in tutto il mondo esattamente cento anni fa. Infatti, le sue parole risultano ancora oggi pertinenti: «Quando le diverse Chiese sono ispirate dall’amore e lo pongono prima di qualsiasi altra cosa nel loro giudizio degli altri e nella relazione gli uni verso gli altri, saranno capaci, invece di accrescere e ampliare i dissensi esistenti, di attenuarli e ridurli il più possibile; e promuovendo un costante interesse fraterno per la condizione, la stabilita e la prosperità delle altre Chiese, con il loro forte desiderio di vedere che cosa sta accadendo in quelle Chiese, e ottenendo una più accurata conoscenza di esse, e con la loro disponibilità a dare, ogni volta che si presenterà l’occasione, una mano di aiuto e di assistenza, allora faranno e otterranno molte cose buone per la gloria e a beneficio sia di se stesse sia dell’intero corpo cristiano, e per il progresso del tema dell’unione».
Possiamo rendere grazie a Dio per il fatto che le relazioni tra la Chiesa cattolica e il Patriarcato ecumenico sono cresciute molto nell’ultimo secolo, anche se continuiamo ad anelare all’obiettivo della restaurazione della piena comunione espressa attraverso la partecipazione allo stesso altare eucaristico. Sebbene gli ostacoli rimangano, sono fiducioso che camminando insieme nell’amore reciproco e perseguendo il dialogo teologico, raggiungeremo questo obiettivo. Tale speranza è basata sulla nostra fede comune in Gesù Cristo, inviato da Dio Padre per riunire tutti gli uomini in un corpo, e pietra d’angolo della Chiesa una e santa, santo tempio di Dio, nella quale tutti noi siamo pietre viventi, ognuno secondo il proprio particolare carisma o ministero conferitogli dallo Spirito Santo.
Con questi sentimenti, rinnovo i miei migliori auspici per la festa di sant’Andrea, e scambio con Sua Santità un abbraccio di pace nel Signore.
Roma, san Giovanni in Laterano, 30 novembre 2020
Francesco

 San Basile è un comune di 1.025 abitanti. Sorge alle falde del Monte Pollino, nel versante nord/est della catena costiera nel Parco nazionale del Pollino.
San Basile è un comune di 1.025 abitanti. Sorge alle falde del Monte Pollino, nel versante nord/est della catena costiera nel Parco nazionale del Pollino.
Il paese, fondato verso il 1475-1480 da albanesi giunti in Italia per sfuggire alla conquista turca dei Balcani, sorse intorno al cenobio di San Basilio Craterete, da cui deriva anche il nome. I profughi ripopolarono la zona intorno al monastero basiliano (oggi Santuario) di Santa Maria Odigitria, cioè “Colei che indica la via”.
L’unica parrocchia presente è dedicata a San Giovanni Battista. La chiesa omonima è stata costruita dopo la venuta degli albanesi, verso la metà del XVIII secolo, ed inaugurata nel 1791. Lavori ben più ampi furono eseguiti sulla costruzione per interessamento della Curia Vescovile di Cassano, da cui San Basile dipendeva, conferendo alla chiesa uno stile che non è propriamente bizantino, ma tardo-barocco, a tre navate. L’esterno dell’edificio si mostra semplice, con un campanile non molto alto, dotato di campane costruite nel XVI secolo, sicuramente appartenute al Monastero di Colloreto. Per adattare lo stile alle particolari esigenze del rito bizantino, negli anni ‘30 è stato sostituito l’altare maggiore con un altare quadrato, sormontato da un baldacchino: una lapide all’interno della chiesa ci informa che l’inaugurazione dell’altare greco e dell’iconostasi avvenne il 21 novembre 1938 da Mons. Giovanni Mele, primo vescovo dell’Eparchia di Lungro, essendo parroco Giuseppe Schirò. Come in tutte le chiese bizantine, l’altare è separato dal resto della chiesa da un tramezzo ligneo detto “iconostasi”. Le icone dell’iconostasi centrale sono opera di Stefano Armakolas.
Per adattare lo stile alle particolari esigenze del rito bizantino, negli anni ‘30 è stato sostituito l’altare maggiore con un altare quadrato, sormontato da un baldacchino: una lapide all’interno della chiesa ci informa che l’inaugurazione dell’altare greco e dell’iconostasi avvenne il 21 novembre 1938 da Mons. Giovanni Mele, primo vescovo dell’Eparchia di Lungro, essendo parroco Giuseppe Schirò. Come in tutte le chiese bizantine, l’altare è separato dal resto della chiesa da un tramezzo ligneo detto “iconostasi”. Le icone dell’iconostasi centrale sono opera di Stefano Armakolas.  Anche le due navate laterali terminano con due iconostasi dello stesso stile di quella centrale: quella di sinistra è stata dipinta da Maria Galie ed è dedicata a S. Giovanni Battista; quella di destra è dedicata alla Madre di Dio e le icone sono opera di Felice Fiore. Sono presenti in chiesa anche opere di altri iconografi: l’Archimandrita Mario Pietro Tamburi di San Basile, Luigi Manes, Josif Droboniku, Anna Marinaro. Sono presenti affreschi della vita di S. Giovanni Battista sulla navata centrale e affreschi di scene del Vangelo sulle pareti del Vima, tutte opere di Riccardo Turrà, eseguite nel 1955.
Anche le due navate laterali terminano con due iconostasi dello stesso stile di quella centrale: quella di sinistra è stata dipinta da Maria Galie ed è dedicata a S. Giovanni Battista; quella di destra è dedicata alla Madre di Dio e le icone sono opera di Felice Fiore. Sono presenti in chiesa anche opere di altri iconografi: l’Archimandrita Mario Pietro Tamburi di San Basile, Luigi Manes, Josif Droboniku, Anna Marinaro. Sono presenti affreschi della vita di S. Giovanni Battista sulla navata centrale e affreschi di scene del Vangelo sulle pareti del Vima, tutte opere di Riccardo Turrà, eseguite nel 1955.
In paese, poi, è presente la chiesa di S. Anna che sorge sulla parte alta del paese. Si tratta di una piccola cappella di pochi metri quadrati con altare a muro, sovrastato da un affresco raffigurante S. Anna; altri affreschi si trovano nelle pareti laterali.
In via Veneto si trova un’altra piccola chiesetta denominata Kopela Don Çiçillit.
In parrocchia dal 1927 sono presenti le Rev. Suore “Piccole Operaie dei Sacri Cuori”, congregazione fondata dal Beato Francesco Maria Greco. Opera principale delle suore è l’educazione dei più piccoli con l’asilo parrocchiale e la catechesi.
Manifestazioni religiose:
Gennaio
La Grande Santificazione delle acque
Febbraio
Triduo in preparazione alla Commemorazione di tutti i defunti
Maria Odigitria – 12 febbraio
Marzo-Aprile
Domenica I di Quaresima: Processione con le Icone
San Giuseppe, sposo di Maria – 19 Marzo
Grande e Santa Settimana.
Santa Pasqua.
Maggio-Giugno
Lunedì e martedì dopo Pentecoste: Festa dell’Odigitria;
San Giovanni Battista, in occasione del III ritrovamento del venerando Capo – 25 maggio Corpus Domini;
13 giugno: S. Antonio da Padova;
Agosto
Dormizione della SS. Madre di Dio – 14 agosto
Dicembre
Immacolata Concezione di Maria (concezione di S. Anna) – 8 Dicembre
Santo Natale.
La sera del 18 marzo in tutte la gjitonie (rioni) sono allestiti falò votivi in onore di San Giuseppe, Fukarecat. Fino a qualche decennio fa intorno al fuoco si cantava la kalimera della Passione di Cristo.
Il Giovedì Santo, al termine delle celebrazioni liturgiche, ci si riunisce in chiesa per il canto della Kalimera della Passione di Cristo, opera attribuita al Sac. Giulio Variboba. Gli uomini si riuniscono intorno all’altare mentre le donne stanno in chiesa, cantando tutta l’opera in albanese per oltre un’ora.
La Vallja, che anticamente si svolgeva il pomeriggio della domenica di Pasqua, il lunedì e il martedì, oggi si svolge solo il martedì. Secondo la tradizione, essa aveva luogo per rievocare e festeggiare una grande vittoria riportata da Skanderbeg sugli invasori turchi proprio nell’imminenza della Pasqua cristiana, la battaglia di Kruja il 24 aprile 1467.

ACQUAFORMOSA – Domenica 8 novembre nella Chiesa Parrocchiale “San Giovanni Battista” di Acquaformosa, S. E. Mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro, durante la celebrazione della Divina Liturgia, ha conferito l’ordine del Presbiterato al diacono Francesco Saverio Mele, un «momento di Chiesa» così come lo ha definito il vescovo Donato nell’Omelia.
Zoti Francesco Saverio Mele, nato a Castrovillari (CS) il 01/04/1991 ha frequentato il liceo scientifico “E. Mattei” a Lungro e, dopo aver conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia presso l’Istituto Teologico Cosentino di Rende, durante gli anni in cui ha frequentato il Seminario Maggiore Eparchiale a Cosenza, ha intrapreso il cammino romano, come Seminarista residente al Pontificio Collegio Greco, che lo ha portato a conseguire la Licenza in Diritto Canonico presso il Pontificio Istituto Orientale; nello stesso Pontificio Istituto si appresta ora a conseguire il Dottorato.
Il Vescovo Donato nella sua Omelia ha ricordato al novello sacerdote che «è sempre il Signore il protagonista e il promotore di ogni bene che si genera nella Chiesa e nella vita degli uomini». Inoltre, mons. Oliverio ha invitato il novello presbitero a vivere la Parola di Dio in quanto «Gli uomini di oggi si aspettano dal sacerdote, prima che la parola “annunciata”, la parola “vissuta”». In questo modo, vivendo la Parola nella testimonianza, il sacerdote sarà uomo di Cristo, uomo di preghiera, uomo che alla sera potrà arrivare a casa «stanco ma avendo amato un po’ di più il Signore, avendo creduto un po’di più in Lui e così dicendo: “Sono servo inutile. Ho fatto quanto dovevo fare”».
Al termine della Divina Liturgia, che ha visto una presenza limitata di celebranti a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19, papàs Mele ha rivolto un saluto ai presenti e ha rivolto un pensiero di gratitudine a quanti lo hanno accompagnato con la preghiera in un momento di grazia della sua vita.

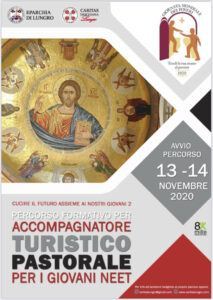
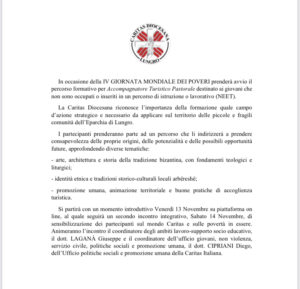

 A Bari, nella chiesa di San Giovanni Crisostomo, in Arco San Giovanni, a pochi passi dal castello normanno-svevo e dalla Basilica di San Nicola, ha vita una comunità cattolica di rito bizantino, a testimonianza dello stretto legame che Bari ancora conserva con il suo passato.
A Bari, nella chiesa di San Giovanni Crisostomo, in Arco San Giovanni, a pochi passi dal castello normanno-svevo e dalla Basilica di San Nicola, ha vita una comunità cattolica di rito bizantino, a testimonianza dello stretto legame che Bari ancora conserva con il suo passato.
È la più antica chiesa di Bari ed è una comprovata testimonianza dei luoghi nicolaiani dato che nella Leggenda di Kiev, la chiesa di San Giovanni “Prodromos”, vicina al mare, viene indicata come primo luogo di deposizione delle reliquie; certamente si tratta proprio della chiesa di San Giovanni in seguito intitolata al Crisostomo.
Possiamo ritenere che le origini di questa chiesa risalgano al 1032, anno in cui il catapano del Thema di Longobardia Photos Argyros (dal luglio 1029 fino a giugno 1032) la fece edificare in località “puteum Greci”, fuori dalle mura della città.
Il 5 maggio del 1957 l’arcivescovo di Bari Enrico Nicodemo la costituì parrocchia di rito bizantino, affidandola alla comunità greca locale che ne cambiò la dedica in San Giovanni Crisostomo. Il 18 novembre 1964 vi fu una dichiarazione integrativa della Sacra Congregazione per le Chiese orientali con la quale si estendeva la giurisdizione del Proistamenos sui fedeli del medesimo rito che dimoravano in tutta la Puglia e nella provincia di Matera.
La facciata è composta da conci squadrati in pietra calcarea e termina con una cuspide interrotta a destra dalla presenza di un campanile a vela. Il portale, collocato in posizione centrale, è incorniciato da un arco con motivi a punta di diamante quasi totalmente rifatto sulla base di frammenti originari. Una finestra rettangolare posta in alto in posizione centrale riprende, nella cornice, lo stesso motivo decorativo del portale, anch’esso riproposto partendo da pochi frammenti originari superstiti.
 L’interno è a navata unica coperta da capriate lignee. Sulla parete destra affiorano due archi a tutto sesto che poggiano su capitelli posti alla quota dell’attuale pavimento. Ciò fa ritenere che il livello originario dovesse trovarsi qualche metro al di sotto dell’odierno calpestio e che i due arconi sono quanto rimane dell’originario edificio. La chiesa, infatti, nella sua struttura originaria, era formata da tre navate: il primitivo impianto terminava con un’abside a cui fa esplicito riferimento documento del 1091. Gli interventi della seconda metà del XIII sec. che portarono il sollevamento della chiesa all’attuale livello, la ridussero ad un’unica navata, coperta da una volta a botte unghiata. A sinistra della navata è collocata una lastra in pietra del sec. XI che raffigura un leone alato ed un grifo che atterrano rispettivamente un caprone ed un cinghiale: essi si dispongono simmetricamente ai lati “dell’albero della vita”, il cui vertice racchiude una piccola croce bizantina. Il presbiterio, di struttura tardo medioevale che si affaccia nell’aula ecclesiale con un ampio arco ogivale, è coperto da una volta a crociera costolonata.
L’interno è a navata unica coperta da capriate lignee. Sulla parete destra affiorano due archi a tutto sesto che poggiano su capitelli posti alla quota dell’attuale pavimento. Ciò fa ritenere che il livello originario dovesse trovarsi qualche metro al di sotto dell’odierno calpestio e che i due arconi sono quanto rimane dell’originario edificio. La chiesa, infatti, nella sua struttura originaria, era formata da tre navate: il primitivo impianto terminava con un’abside a cui fa esplicito riferimento documento del 1091. Gli interventi della seconda metà del XIII sec. che portarono il sollevamento della chiesa all’attuale livello, la ridussero ad un’unica navata, coperta da una volta a botte unghiata. A sinistra della navata è collocata una lastra in pietra del sec. XI che raffigura un leone alato ed un grifo che atterrano rispettivamente un caprone ed un cinghiale: essi si dispongono simmetricamente ai lati “dell’albero della vita”, il cui vertice racchiude una piccola croce bizantina. Il presbiterio, di struttura tardo medioevale che si affaccia nell’aula ecclesiale con un ampio arco ogivale, è coperto da una volta a crociera costolonata.
Con l’affidamento della chiesa alla comunità di rito bizantino, l’altare maggiore di stile barocco fu sostituito con uno a forma quadrata, preceduto da una  iconostasi dipinta in tre ordini: nella parte superiore sono raffigurati i santi Apostoli che fanno da corona all’icona posta al centro dove è raffigurata la Deesis, cioè la supplica, con il Cristo in trono a ai lati la Madre di Dio e san Giovanni il Battista che rivolgono suppliche in favore dei fedeli, scene delle feste dell’anno liturgico distribuiti in pannelli e in quella inferiore quattro figure ieratiche: il Cristo Pantocrator, la Madre di Dio, San Giovanni Battista e San Giovanni Crisostomo. Al centro dell’abside vi è una tela della Madonna con le mani volte in alto ed il Divino Infante sul petto a firma di M. Buono 1968. Sulle porte diaconali sono dipinti due arcangeli e sulle porte regali è raffigurata l’Annunciazione.
iconostasi dipinta in tre ordini: nella parte superiore sono raffigurati i santi Apostoli che fanno da corona all’icona posta al centro dove è raffigurata la Deesis, cioè la supplica, con il Cristo in trono a ai lati la Madre di Dio e san Giovanni il Battista che rivolgono suppliche in favore dei fedeli, scene delle feste dell’anno liturgico distribuiti in pannelli e in quella inferiore quattro figure ieratiche: il Cristo Pantocrator, la Madre di Dio, San Giovanni Battista e San Giovanni Crisostomo. Al centro dell’abside vi è una tela della Madonna con le mani volte in alto ed il Divino Infante sul petto a firma di M. Buono 1968. Sulle porte diaconali sono dipinti due arcangeli e sulle porte regali è raffigurata l’Annunciazione.
Attualmente la Parrocchia è retta da Papas Antonio Magnocavallo, dell’Eparchia di Lungro, nominato Parroco nel 1975 da mons. Anastasio Ballestrero, Arcivescovo di Bari, per i fedeli orientali.

Chiesa Parrocchiale dei SS Pietro e Paolo
 Ubicata nel centro storico, la sua origine risale alla fine del secolo XVI e fu aperta al culto nell’anno 1604.
Ubicata nel centro storico, la sua origine risale alla fine del secolo XVI e fu aperta al culto nell’anno 1604.
Presenta una pianta longitudinale ed è orientata a Est. La facciata, posta a livello stradale, non presenta gradini. La superficie superiore della facciata è caratterizzata da un finestrone centrale e da due oculi laterali in corrispondenza delle rispettive navate. All’esterno sono presenti dei faretti, che al calar del sole la illuminano.
Il campanile è quadrato, di tre piani, con cella campanaria terminante a cuspide. L’interno si presenta a tre navate. In quella di destra si apre una cappella circolare, decorata con stucchi.
Sopra l’altare è collocata un’antica tela raffigura la Madonna del Buon Consiglio; ai piedi della Vergine, in atteggiamento orante, S. Vincenzo Ferreri e S. Caterina da Siena.
Lungo la parete della navata di destra vi sono ubicate varie icone raffiguranti Cristo Sommo Sacerdote, San Vincenzo Ferreri, San Giorgio e San Demetrio, Santa Lucia, i Santi Cosma e Damiano e l’Epitaphios della Madre di Dio.
La navata centrale conserva un soffitto ligneo a cassettoni. Le pareti sono arricchite dalle icone dei Santi Pietro e Paolo, San Nicola di Mira, San Pantaleimon, San Spiridione e di Santa Teodora. Sopra il portale d’ingresso principale è ubicato il Coro, ove è situato un antico organo a canne. La navata di sinistra presenta: la tela della Madonna del Carmine, l’Epitaphios del Cristo, le icone della Madre del Buon Consiglio, dei Santi Costantino ed Elena, dei santi Arcangeli ed alcune scene iconografiche della vita di Cristo.
 L’illuminazione interna è assicurata da dodici finestre laterali e da una grande finestra centrale, tutte decorate con vetrate artistiche.
L’illuminazione interna è assicurata da dodici finestre laterali e da una grande finestra centrale, tutte decorate con vetrate artistiche.
La chiesa, nel corso degli anni, ha subito vari interventi di restauro e di riqualificazione al fine di conformarla ai requisiti caratterizzanti le chiese di rito Bizantino.
Negli anni ‘40 del XX secolo Papàs Giovan Battista Tocci fece rimuovere dall’abside l’altare proprio del rito Romano sostituendolo con un altare provvisorio mobile di forma quadrata, sorretto da un piede centrale in mattoni; inoltre all’interno dell’Abside vi sono le due nicchie laterali della Prothesis e del Diakonikon.
Particolare è la finestra a campana che assicura l’illuminazione dell’abside.
 Mons. Ercole Lupinacci, già parroco (1963-1981), continuò nell’opera di adattamento al rito Bizantino, rimuovendo gli altari delle navate laterali.
Mons. Ercole Lupinacci, già parroco (1963-1981), continuò nell’opera di adattamento al rito Bizantino, rimuovendo gli altari delle navate laterali.
Nell’anno 2003 il parroco Papàs Pietro Minisci (1982 – 2018) fece erigere l’Iconostasi, opera del falegname Giuseppe Serembe, in legno di noce. In essa sono incastonate le icone del Cristo, della Madre di Dio e degli Evangelisti. Nella Porta Regia è raffigurata l’Annunciazione, mentre in quelle diaconali gli Arcangeli Michele e Raffaele. Il registro superiore dell’iconostasi consta delle icone dei quattro evangelisti. Sopra tale ordine, infine, vi è l’icona della Cena Mistica.
 Oggi la chiesa si presenta in una nuova veste e i lavori sono proseguiti da Papàs Giuseppe Barrale, attuale Amministratore Parrocchiale (2018). L’altare centrale è stato riqualificato secondo i criteri tipici della tradizione orientale e per come è prescritto dai codici liturgici e canonici orientali: si presenta con un piano di marmo quadrato, sorretto da quattro colonne marmoree, le quali rappresentano i quattro evangelisti. L’interno della chiesa, totalmente ritinteggiata, è illuminato da nuovi lampadari, arricchito da nuove icone e da un nuovo Trono Episcopale, nonché diverse suppellettili liturgiche, proprie del rito bizantino.
Oggi la chiesa si presenta in una nuova veste e i lavori sono proseguiti da Papàs Giuseppe Barrale, attuale Amministratore Parrocchiale (2018). L’altare centrale è stato riqualificato secondo i criteri tipici della tradizione orientale e per come è prescritto dai codici liturgici e canonici orientali: si presenta con un piano di marmo quadrato, sorretto da quattro colonne marmoree, le quali rappresentano i quattro evangelisti. L’interno della chiesa, totalmente ritinteggiata, è illuminato da nuovi lampadari, arricchito da nuove icone e da un nuovo Trono Episcopale, nonché diverse suppellettili liturgiche, proprie del rito bizantino.
Celebrazioni settimanali:
Feriale: ore 8:00 –Divina Liturgia
Festivo: ore 10:30 –Divina Liturgia (nei mesi da luglio a novembre la Divina Liturgia domenicale si celebra presso il Santuario)
Vespri delle Feste Despotiche e Theomitoriche ore 16:30
Manifestazioni religiose:
Gennaio
La Grande Santificazione delle acque.
Febbraio
Triduo in preparazione alla Commemorazione di tutti i defunti.
Marzo-Aprile
San Giuseppe, sposo di Maria – 19 Marzo
San Vincenzo Ferreri – 5 Aprile
Grande e Santa Settimana.
Santa Pasqua.
Maggio-Giugno
Festa patronale: Santi Pietro e Paolo, patroni della Parrocchia – 29 Giugno
Luglio
Maria SS.ma del Monte Carmelo – 16 Luglio
Dicembre
Immacolata Concezione di Maria (concezione di S. Anna) – 8 Dicembre
Santo Natale.